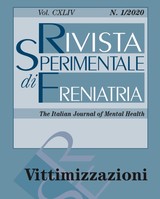
La vittimizzazione è una condizione di tipo processuale caratterizzata da un crogiolo di inestricabili dinamiche relazionali vittima-perpetratore, di vulnerabilità, sofferenza, vissuti ed emozioni cui non sono estranee rappresentazioni socialmente determinate. La complessità della condizione vittimale, esposta a proiezioni e meccanismi difensivi collettivi, pregiudizi e manipolazioni, alimenta il rischio di una recursività impotente e dolorosa, che può trasformare profondamente e stabilmente l’identità cristallizzando il ruolo sociale e condizionando la percezione del mondo e delle relazioni come luogo insicuro.
EDITORIALE La vittimizzazione è una condizione di tipo processuale caratterizzata da un crogiolo di inestricabili dinamiche relazionali vittima-perpetratore, di vulnerabilità, sofferenza, vissuti ed emozioni cui non sono estranee rappresentazioni socialmente determinate. La complessità della condizione vittimale, esposta a proiezioni e meccanismi difensivi collettivi, pregiudizi e manipolazioni, alimenta il rischio di una recursività impotente e dolorosa, che può trasformare profondamente e stabilmente l’identità cristallizzando il ruolo sociale e condizionando la percezione del mondo e delle relazioni come luogo insicuro. Già il Libro di Giobbe descrive il ritrovarsi vittima senza colpa di eventi negativi e la difficoltà di trovare un senso a quanto accade. Nella logica vetero-testamentaria questo pone il problema di come Dio premi o castighi le azioni degli uomini e se sia prevista una riparazione individuale o collettiva, terrena o ultraterrena. Giobbe testimonia attraverso la propria vita che esistono giusti che soffrono crudelmente. Il lettore sa che i suoi mali vengono da Satana e non da Dio e che sono una messa alla prova della sua fedeltà, ma Giobbe non lo sa, né lo sanno i suoi amici. Quale potrà essere allora la spiegazione? Essi avanzano risposte convenzionali: la felicita? degli empi è di breve durata; la disgrazia del giusto saggia la sua virtù; la pena castiga colpe commesse per ignoranza o debolezza. Contro la rigida correlazione colpa-punizione, Giobbe si solleva con tutta la forza della sua innocenza. Non nega la riparazione terrena, la attende anzi e Dio alla fine gliela concederà, ma per lui è una sofferenza in più che tale riparazione gli venga rifiutata nel presente e si affanna a cercare invano il senso della prova cui è sottoposto. Lotta disperatamente per ritrovare un Dio che si nasconde e che egli si ostina a credere buono. La risposta di Dio non risolverà il problema, rivelerà solo la trascendenza del suo essere e dei suoi disegni e ridurrà alla fine Giobbe al silenzio. Violenza, sofferenza e sacrificio sono sempre stati presenti nella storia e nei riti delle religioni primitive. La violenza può accendersi per desiderio mimetico, a causa del quale nelle comunità tutti vogliono ciò che hanno o desiderano gli altri. Studiosi come Girard individuano all'origine di ogni società umana un assassinio rituale, che riconosce alla vittima sacrificale attributi divini e sacrali, proprio perché la sua uccisione funge da mezzo per canalizzare e neutralizzare la violenza. Nel sacrificio della vittima il ciclo della violenza trova il suo epilogo, mentre la cultura e la società vengono fondate e riorganizzate sotto la protezione minacciosa del sacro, che si costituisce come proiezione difensiva della violenza. Per effetto di scenari collettivi ed individuali, dalle grandi guerre del secolo scorso fino alle attuali recrudescenze delle guerre di religione, da una temperatura sempre più violenta delle relazioni umane anche intra-familiari fino ai reati contro l'ambiente, la condizione di vittima sembra assumere una dimensione immanente e pervasiva, anche nel caso in cui l’azione dannosa non configuri una specifica fattispecie di reato. I processi di danno-vittimizzazione rischiano dunque di accadere naturaliter, entro un ambiente culturale contrassegnato da specifici elementi di vulnerabilità socio-psicologica globale, che riconoscono componenti politiche, economiche e culturali con riferimento, in particolare, al ruolo delle dinamiche di marginalizzazione ed esclusione. Non a caso, tra le persone vulnerabili vi sono prevalentemente minori, donne, migranti e soggetti marginali. Dal punto di vista individuale esiste un collegamento possibile tra trauma e vittimizzazione. Una condizione traumatica può avere origine precocemente a causa di un fallimento delle garanzie affettive primarie. Questo può generare una atmosfera traumatica, che indica l’effetto pervasivo che l’abuso cronico e la trascuratezza hanno nell’infanzia sui regolatori neurobiologici e psicologici, determinando un auto-mantenimento della vulnerabilità traumatica. E' questo il processo che può innescare il rischio di vittimizzazione durante tutto il corso della vita. All’interno di queste dinamiche psicologiche vengono fissate nuove regole, alcune delle quali contrarie ad ogni logica condivisa, dal momento che la violenza crea implicitamente una rottura degli universi di riferimento. Bettelheim sottolinea che una persona esposta a condizioni estreme può comportarsi in un modo che essa stessa può non approvare e perdonarsi. L’adesione e l’adattabilità a queste circostanze sono al di là di quanto l’individuo possa prevedere ed aspettarsi. Il dolore morale che ne deriva è caratterizzato da suggestionabilità, sottomissione impotente e da una condizione di severa dissonanza cognitiva. Ciò può sostenere una frammentazione della identità e della immagine di sè e di sè con l’altro, che espone il soggetto al rischio di ulteriori dinamiche di vittimizzazione o a forme di vittimizzazione secondaria e puo? richiedere interventi non solo sotto il profilo clinico-terapeutico ma, auspicabilmente, soprattutto sotto quello sociale-riparativo. I contributi di questo numero della Rivista di Freniatria intendono esplorare questo campo complesso, in cui variabili personali, relazionali, culturali e sociali concorrono a determinare processi di danno-vittimizzazione, che possono riguardare l’individuo ma anche la collettivita. E propongono un nuovo paradigma caratterizzato da una profonda rivendicazione della centralità della persona e dell'intersoggettività nell'analisi del problema e nella individuazione di soluzioni mirate. Da ciò emerge la necessità di una prospettiva partecipata, victim-oriented, che includa il punto di vista, la narrazione, i bisogni emergenti anche di chi è vittima nella costruzione di politiche di prevenzione e di interventi riparativi mirati. Susanna Vezzadini in Vittime e società: per la ricostruzione delle reti fiduciarie violate analizza la dimensione sociale della vittimizzazione, in particolare relativamente al ruolo svolto da processi di carattere storico- politico, economico-strutturale, culturale-relazionale nel condizionare stati di vulnerabilità sociale. In questa prospettiva, i processi di vittimizzazione riconoscono dinamiche sociali diffuse ed allargate, che hanno a che vedere con disuguaglianze ed ingiustizie che possono esitare in esclusione e marginalizzazione. L’A. pone l’accento sulla ambivalenza della rappresentazione sociale del ruolo di vittima, esposta alle proiezioni dicotomiche della idealizzazione e della colpevolizzazione, entrambe rassicuranti e confortanti rispetto al bisogno di mantenere una visione del mondo che restituisca alla persona comune una sensazione di efficacia e di controllo sulla vita. Nella prospettiva giuridico-penale italiana la figura della vittima è assimilata al ruolo passivo di persona offesa, anche se il sistema processuale accusatorio, introdotto dal nuovo codice di procedura penale, ha attribuito alla vittima un ruolo più incisivo nel processo. Ma è soprattutto nella attività degli organismi internazionali che le vittime di reato hanno assunto negli ultimi decenni una rilevanza crescente, mediante una evoluzione caratterizzata da numerosi provvedimenti del Consiglio d’Europa e del Parlamento europeo e dallo sviluppo della vittimologia come scienza. Susanna Pietralunga e Claudia Salvioli in Aspetti criminologici e giuridici sulla vittima, con particolare riguardo al minore focalizzano l’attenzione sulle dinamiche relazionali e situazionali vittima-autore di reato. Il ruolo della vittima nell’azione vittimizzante rappresenta una questione estremamente controversa, che ha ispirato diversi modelli interpretativi e che necessita di un approccio sistemico. Un altro aspetto rilevante riguarda l’instabilità dei ruoli vittima/ perpetratore, interscambiabili e strettamente interdipendenti in alcuni casi a seconda degli aspetti situazionali e del punto di vista dell’osservatore/ narratore. Sono soprattutto i minori ad essere esposti, per effetto di una vulnerabilità personale, situazionale e familiare, ad una forte instabilità di ruolo che può porli ora nella posizione di vittima ora in quella di autore di reato. In particolare, la accessibilità e l’interattività che contraddistinguono i nuovi media, sia per quanto concerne l’attività ludica che la ricerca di forme di socializzazione, contribuiscono alla creazione di nuovi scenari estremamente immersivi ed a rischio. Da qui il pericolo che si vengano a determinare da un lato nuove forme di dipendenza e di vittimizzazione, dall’altro nuovi profili di reato legati al cyberspace, condizioni entrambe richiedenti tutela. In tema di reati contro i minori il figlicidio, nelle sue diverse tipologie giuridiche e motivazionali, rappresenta per definizione il crimine contro natura. Tra i sacrifici rituali l’uccisione del primogenito attraversa quasi tutte le culture e le confessioni religiose, insieme a dispositivi di estrema, misericordiosa messa in sicurezza. Come nel Vecchio Testamento il sacrificio di Isacco, in cui nell’ultimo istante viene sostituito al fanciullo un agnello; come i rituali fenici, dove il sorriso forzato del genitore per il privilegio della offerta del figlio diviene un ghigno spaventoso capace di distogliere lo sguardo della divinità stessa: è quello l’attimo che consente di vicariare la vittima umana con un animale. Miriana Biancofiore, Monica Ostuni, Claudia Perri, Ignazio Grattagliano in Il Figlicidio: aspetti criminologico clinici e psicologico-psichiatrico forensi esaminano la costellazione dei fattori di rischio che aumentano la vulnerabilità del sistema genitori-bambino, tra cui non sono da trascurare gli esiti di traumatizzazioni precoci dei genitori che possono perpetuare una violenza trans-generazionale. Anche in questa area l’analisi epidemiologica assume rilevanza centrale rispetto alla previsione di qualsiasi intervento di prevenzione, che restauri e supporti il lavoro della genitorialità. La dimensione intima della vittimizzazione interessa in modo particolare anche le donne, come nel caso del maltrattamento prolungato entro le mura di una casa familiare. Passando attraverso la tortura calcolata e l’utilizzo da parte del partner violento del terrore e della disumanizzazione, di pratiche umilianti e dolorose, si può giungere fino all’omicidio. Dal punto di vista psicologico, le dinamiche correlate possono originare organizzazioni difensive stabili e molto resistenti al cambiamento. Chi maltratta allo scopo inconsapevole di esteriorizzare i propri conflitti tende a stabilire con la vittima un intenso ed ambivalente legame di mutua dipendenza. L’altro viene controllato, manipolato come se fosse un oggetto parziale, ridotto a destinatario passivo ed impotente della identificazione proiettiva del soggetto, di un controllo onnipotente sulla vita e sulla morte e di una violenza che nega qualsiasi alterità ed autonomia. Heidi Stockl e Coll. in Issues in measuring and comparing the incidence of intimate partner homicide and femicide – A focus on Europe analizzano, dal punto di vista epidemiologico, l’incidenza in Europa dell’omicidio tra partner, da cui è più interessato il sesso femminile. La difficolta? sottolineata dagli AA. riguarda la rilevazione con trasparenza ed omogeneità dei dati, che risultano necessari per gli opportuni interventi di prevenzione. Studi recenti confermano che l’auto-mantenimento dei processi di vittimizzazione attraverso le generazioni può riconoscere un meccanismo di trasmissione su base neurobiologica. Lo stile di attaccamento precoce può, infatti, influenzare la neuroplasticità attraverso processi di trascrizione genomica a mediazione neuro-endocrina. E' per questo tramite che eventi di traumatizzazione subiti da un genitore possono ripercuotersi sui figli dando origine a quadri clinici complessi di matrice somato-psichica. Anna Maria Scapicchio e Maria Gloria Gleijeses in Trasmissione transgenerazionale dell’abuso e terapia EMDR descrivono, attraverso il trattamento di un caso di traumatizzazione complessa, la efficacia di un approccio integrato tra EMDR, teoria dell’attaccamento e della dissociazione strutturale. Negli ultimi decenni è cresciuta l'attenzione verso reati e conseguenti profili di vittimizzazione che possono riguardare l’ambiente e la collettività, non solo umana. La cosiddetta Green Criminology si occupa di danni e crimini che riguardano l’ambiente a partire, ad esempio, dall’inquinamento, dalla perdita di biodiversità, dal depauperamento di risorse naturali fino ai cambiamenti climatici. In Understanding environmental victimization from a green criminological perspective Lorenzo Natali sottolinea come in questo campo la natura del danno e della vittimizzazione sia un processo sociale attivo, che implica complesse dinamiche di potere-controllo, nonché severe resistenze verso l’accertamento della responsabilità. Insieme alla difficoltà di definire cosa sia un crimine ambientale, chi ne sia l’autore, quale sia il nesso causa- effetto e di conseguenza quali siano i possibili profili di vittimizzazione. La rilevanza in questa area degli aspetti simbolico-culturali e della percezione sociale richiede una analisi partecipata, in cui possa trovar luogo, accanto alle di vista dell’individuo e della comunità di appartenenza. Un tema assolutamente centrale nell’analisi dei processi di vittimizzazione riguarda come occuparsi delle persone che subiscono le conseguenze di eventi dannosi e traumatici, che possono configurarsi anche come reati. Il trauma irrompe sulla scena del quotidiano vissuto, in dimensioni più o meno catastrofiche, sovvertendo le usuali rappresentazioni individuali e collettive del vivere, le reti di comunicazione interpersonale, i processi di attribuzione di senso, le proiezioni del sè concernente. E più ancora dell’evento primario, le catene di eventi successivi, nei termini di risposte inappropriate o di mancate risposte, rischiano di moltiplicare gli effetti distruttivi che possono cristallizzare la persona nel ruolo di vittima. Giovanni Mierolo in I Servizi di Victim Support. L’esperienza di Rete Dafne descrive un servizio pubblico e gratuito per l’assistenza alle persone vittime di reato. I servizi di assistenza alle vittime operano in uno spazio di connessioni interstiziali, che gli eventi hanno disarticolato, per ricostruire funzioni di rete che possano sostenere gli individui, che rischiano altrimenti di rimanere sempre più soli di fronte ad un dolore senza nome. Obiettivo della presa in carico è aiutare la persona a comprendere, interpretare, descrivere, parlare, nominare per far transitare le vicende traumatiche verso il campo della comprensione e verso un piano simbolico, per stabilire confini e per limitare la confusione tra le cose, le persone, il lecito e l’illecito. Per ricostruire speranza.